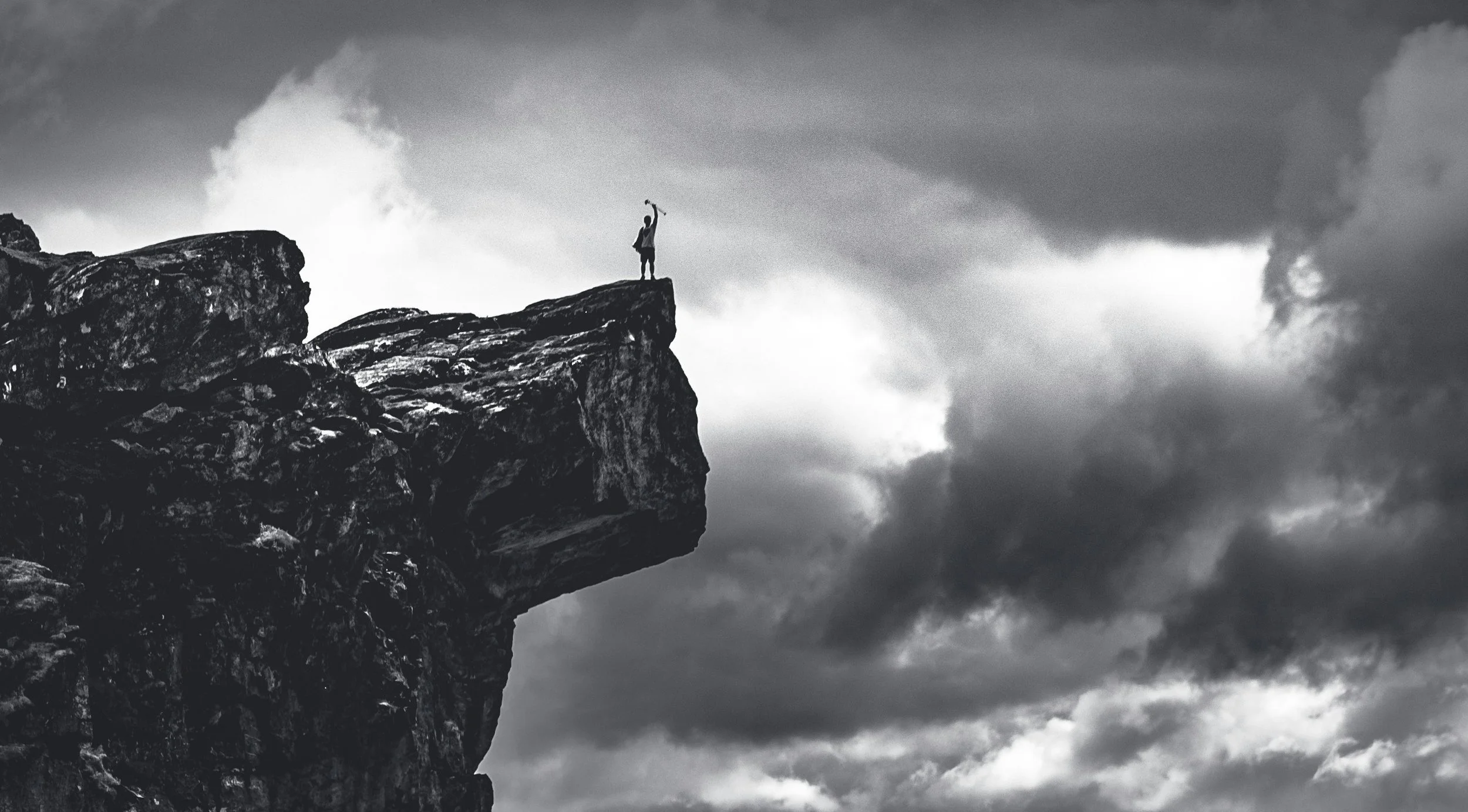Personæ (I)
Le parti della personalità che inconsapevolmente releghiamo nell’ombra, perché inaccettabili e lesive della nostra integrità, finiamo per proiettarle e giudicarle amaramente, e proprio perché non le vediamo in noi stessi, le condanniamo.
Ne “Il ritorno dell’eroe”, film del 2018 di Laurent Tirard, queste parti, le ritroviamo incarnate nell’ironico personaggio del capitano Neuville (Jean Dujardin).
Altro “eroe senza self control” (E.Morin), lo troviamo nel film Zarak Khan, di Terence Young, del 1956, eroe non del tutto positivo, il cui compito è quello di espiare la propria violenza primitiva. La metafora dell’eroe è molto gettonata nel cinema e ci rimanda a temi psicologici.
Nella teoria junghiana l’eroe (archetipo dell’Io) è chiamato ad intraprendere un viaggio che rappresenta un percorso evolutivo, di crescita interiore.
Tornando a Neuville, è l’ironia, messa in scena dal regista in questo film, che ci fornisce una lente edulcorata per osservare con occhi più indulgenti i “difetti” dell’umanità, poiché il sorriso è assicurato di fronte a tale personaggio. Va sullo sfondo il giudizio, sempre pronto, e appare in figura la possibilità di osservare, con la giusta distanza, ciò che ci spaventa di più.
È l’ironia, messa in scena dal regista, che ci fornisce una lente edulcorata per osservare con occhi più indulgenti i “difetti” dell’umanità, poiché il sorriso è assicurato di fronte a tale personaggio. Va sullo sfondo il giudizio, sempre pronto, e appare in figura la possibilità di osservare, con la giusta distanza, ciò che ci spaventa di più.
Neuville, dietro il suo sorriso ammiccante, nasconde le parti meno nobili di noi stessi, come la codardia, l’approfittarsi dell’altro, il mentire, si ravvisano molti tratti narcisistici (non ci soffermiamo su questo tema oggi) e (come per tanti narcisi), comunque, ne siamo affascinati.
Elisabeth (Mélanie Laurent), l’altra protagonista, rappresenta l’opposto del nostro “eroe”. Lei è tutta d’un pezzo, morigerata ed onesta, anche rispetto ai suoi familiari che sembrano in balia dei loro complessi. Il regista ha rappresentato le personalità dei personaggi, nelle loro polari caratteristiche, contrapponendole, e questo è molto interessante, perché all’occhio dello spettatore arriva scisso ciò che è buono e ciò che è cattivo, ma grazie alla leggerezza, non riusciamo ad amare meno uno dell’altra. La parte buona, non corrotta, rappresentata da Elisabeth, sarà l’unica (non a caso) in grado di vedere realmente Neuville, riuscendo ad innamorarsi di lui, nonostante la sua (loro) ombra e a condividere “nefandezze”.
Questa è la metafora che il regista utilizza per inviarci un messaggio di integrazione delle parti. Elisabeth diverrà capace di integrare in sé stessa quei “difetti”, quelle parti oscure, mostrandoci come sia essenziale per la nostra crescita psicologica ed evolutiva, consapevolizzare (Elisabeth è l’unica che sa chi è realmente Neuville), i vari aspetti della nostra personalità, anche quelli meno nobili. Solo così potremo, poco a poco, entrarvi in contatto. Integrare parti avulse della nostra personalità significa poterle tollerare e questo ci consentirà di non essere i nostri peggiori giudici.
Guardare alle nostre debolezze con indulgenza è l’obiettivo principale della nostra crescita psicologica. Se io sarò in grado di avere compassione per me stesso, potrò essere compassionevole con l’altro da me. E questo film lo realizza con il sorriso (una volta tanto).